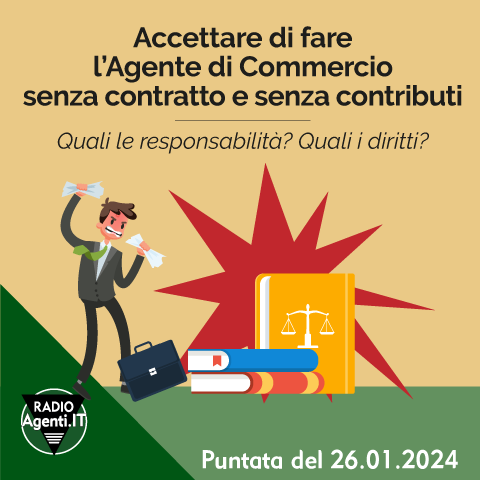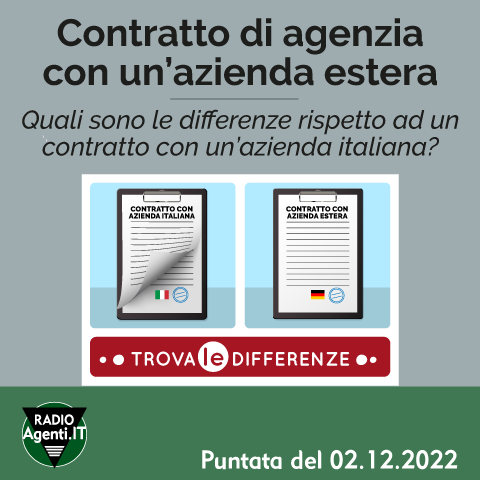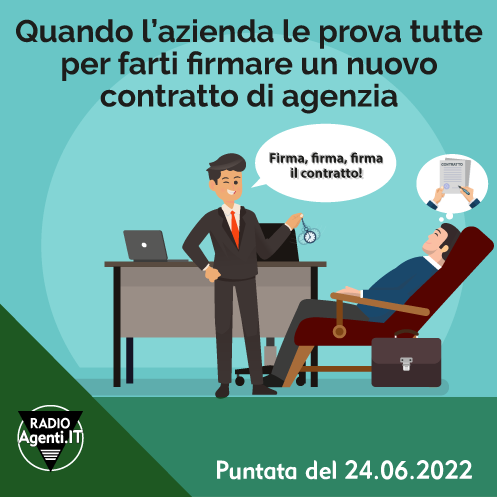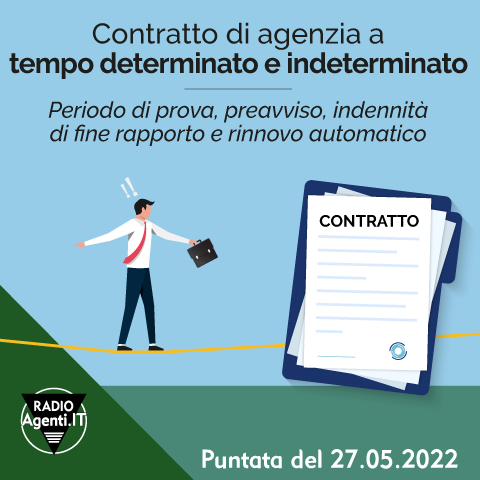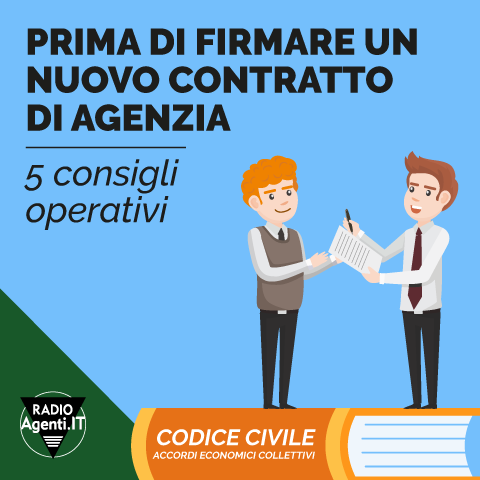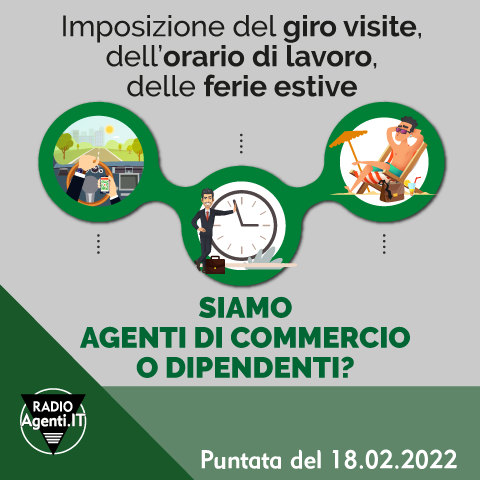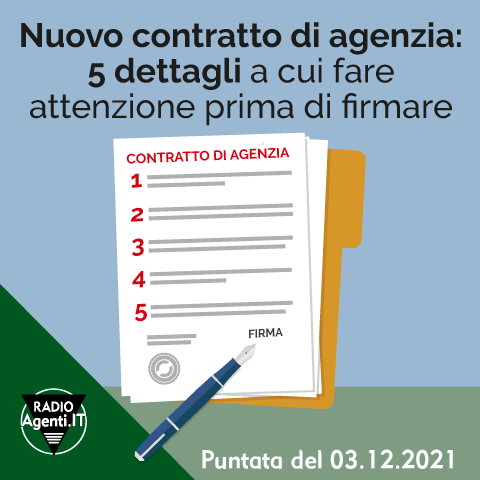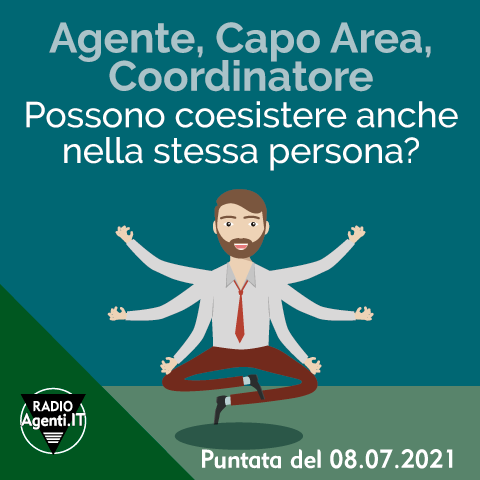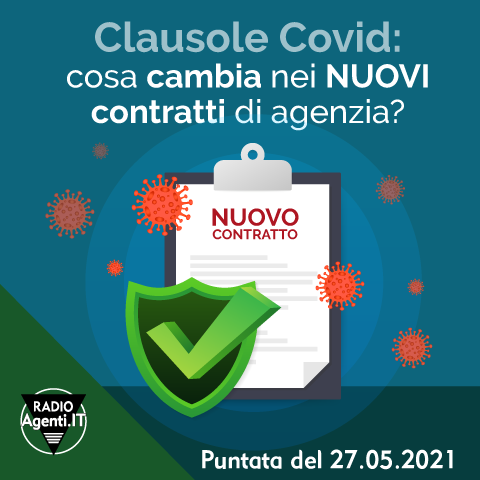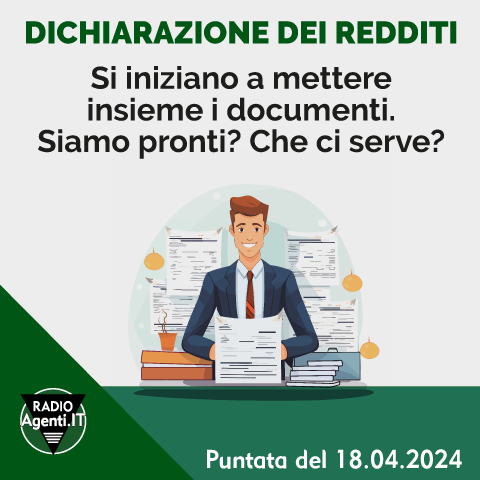La redazione di Obbiettivo Agenti accoglie oggi il quesito di Claudio, agente disdettato da una mandante tedesca che vorrebbe citare in tribunale per una questione economica legata alle indennità.
Claudio ci chiede come gestire una causa con un'azienda straniera e, soprattutto, dove - in Italia o in Germania?
Sembrerebbe una domanda che prevede un facile suggerimento: Claudio dovrebbe consultare il contratto da cui emergerebbe sicuramente il foro competente.
In studio gli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli non liquideranno, però, troppo velocemente la questione, tutt'altro che risolta in maniera semplice. La risposta in diretta alle 13:05.
Il riassunto della puntata:
Claudio, agente disdettato da una mandante tedesca, vorrebbe citarla in tribunale per una questione economica legata alle indennità. Ma quale tribunale: quello italiano o quello tedesco?
Per capire la Germania, partiamo dall'Italia. Come è normata la questione del foro competente nel bel Paese? Qui, si parte da un distinguo. In caso di agente persona fisica, questi gode di una maggiore comodità, ovvero quella di potersi rivolgere al tribunale presso cui è stabilito il suo domicilio. Domicilio, non residenza, che è la dimora abituale. Nel caso dei professionisti del commercio, infatti, spesso il domicilio, quindi il centro dei loro interessi, coincide con l'ufficio, ed è indicato in fattura. Quando l'agente opera come società, quindi come persona giuridica, allora la sede di un eventuale contenzioso sarà quella individuata espressamente dal contratto, solitamente nelle sue ultime righe.
Questa dicotomia si riflette anche in un'altra questione, inscindibile rispetto alla prima. Infatti, sorgendo un contenzioso tra mandante e agente persona fisica, allora si applica la procedura del lavoro - il giudice interpellato sarà quello del lavoro. Non così nel caso in cui l'agente operi in forma societaria, poiché si presuppone che non ci sia la prevalenza della personalità della prestazione: costui dovrà consultare la clausola del contratto relativa al foro competente.
Attenzione, però, al modo in cui tale clausola è redatta, perché l'individuazione del foro sarà vincolante solo se esplicitata in via esclusiva. Quindi, in mancanza di una parola, di una spia linguistica che sottolinei l'esclusività della competenza (come “esclusivo” o “in via esclusiva” e così via), si potrà ricorrere presso tribunali diversi. Ovviamente, anche in presenza di una tale formula, se l'agente è persona fisica, questa clausola non dovrà essere rispettata, e per legge inderogabile ci si rivolgerà al tribunale del suo domicilio. Se invece questa formula non dovesse esserci, l'agente persona giuridica che volesse intentare una causa contro la sua mandante, avrebbe la possibilità di farlo presso il proprio foro: in sostanza, è chi inizia la causa a determinare il foro di riferimento. Infine, se concordi, le parti in causa possono scegliere un altro tribunale, per i più svariati motivi.
A tale proposito, viene richiamato il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, che è quello designato dalla legge a intervenire ancora prima che nasca la controversia. Ovviamente, come sottolineato prima, se le parti sono d'accordo, possono litigare ovunque desiderino, ma se una delle parti decide, unilateralmente, di citare in giudizio l'altra presso un tribunale privo di competenza territoriale nel merito, e l'altra non contesta questo aspetto, a quel punto rimane scelto quel dato tribunale.
Dopo la panoramica sugli usi italiani, i legali rammentano che, qui come altrove in Europa, la questione del tribunale di competenza è regolamentata dalla direttiva CEE del 1986. Se nel contratto è richiamata la giurisdizione italiana, anche indirettamente, le parti devono adire un tribunale italiano, applicando tutte le distinzioni richiamate precedentemente, e seguendo o i contratti economici collettivi, se applicati esplicitamente, o il Codice Civile – modificato proprio a seguito della direttiva CEE.
Tuttavia, nel contratto potrebbe essere dichiarata esplicitamente la giurisdizione tedesca e indicata come foro competente in via esclusiva una città tedesca: ciò non è contestabile, si litiga dunque in Germania. E si litiga al proposito delle provvigioni reclamate da Claudio. Nessun problema: i giuristi tedeschi sanno bene come calcolare, desumere e documentare la fattispecie, e nell'uso del Paese nord europeo si pone particolare attenzione al merito dell'agente, quindi al suo diritto o meno di recepire le indennità, lasciando in secondo piano il quantum, la cifra da corrispondere. Qui, in Italia, l'annualità di cui al 1751 del Codice Civile è considerata come la somma massima, in Germania come la somma minima. Due approcci diversi alla norma.
La diversità nell'approccio si rende manifesta anche in un altro aspetto. In Italia sussistono due possibilità di quantificare le indennità, quella legata agli accordi economici collettivi e quella legata alla legge, al Codice Civile. Quest'ultimo, come lo leggiamo oggi, è stato modificato nel 1991, per effetto della già citata direttiva CEE: fino a quell'epoca, al riguardo delle indennità, rimandava agli accordi economici collettivi. Dopo di allora, ha recepito il principio meritocratico: l'agente riceve le indennità se ha sensibilmente sviluppato gli affari o procurato nuovi clienti e quindi se la mandante ha ricevuto grandi vantaggi dal suo operato.
Tutto ciò non ha però ancora scardinato una mentalità che persiste, nei tribunali italiani, circa la natura del lavoro dell'agente, visto ancora, come agli inizi del secolo scorso, come un parasubordinato, un qualcuno di simile al dipendente. Non come un libero professionista, un autonomo. Questo, purtroppo, osserva amareggiato Bianchi, porta dei conflitti giurisprudenziali con alcuni giudici che mixano la disciplina giuslavoristica con quella del commercio puro.
*****
I contratti con le aziende estere: attenzione all'aspetto linguistico!
La storia di Claudio offre uno spunto ad Obbiettivo Agenti e al suo consulente legale, l'avvocato Lorenzo Bianchi, per parlare di un aspetto che apparentemente può sembrare solo formale, ma che ha implicazioni sostanziali: la lingua del contratto.
Solitamente, la lingua del contratto è quella della mandante, e per cortesia, per far comprendere all'agente cosa sta firmando, si allega una traduzione nella sua lingua madre, inserendo una postilla che stabilisce che, in caso di controversia e di dubbio interpretativo, la versione da consultare sia quella nella lingua dell'azienda.
La questione della traduzione è, dunque, tutt'altro che marginale. Da una lettura comparata effettuata dall'avvocato, per esempio, della direttiva CEE del 1986 nelle lingue inglese, tedesca e italiana, quella che in sostanza ha riformato il diritto commerciale dei paesi dell'Unione, emerge un dato interessante, a proposito del concetto di “esclusività”.
In Italia siamo soliti pensare che, se un agente ha una zona in esclusiva, matura il diritto alle provvigioni indirette. Tuttavia, questo concetto non esiste nelle versioni inglese e tedesca: il diritto alla provvigione non si associa all'esclusività di una zona, ma alla riservatezza. Concetto molto diverso, che ritroviamo anche al secondo comma dell'articolo 1748 del Codice Civile.